andrea bianchini- ritratto
.
PAUL RICOEUR, IL BENE OLTRE LA GIUSTIZIA
Laureanda Alessandra Pierini
Docente relatore Prof. Antonio Pieretti
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Etica delle Relazioni Umane
Anno Accademico 2007-2008
**
1) Alessandra, sono passati alcuni anni dalla tua tesi di laurea che, tra l’altro, ho molto apprezzato per rigore, articolazione, citazione bibliografica. Ora non solo ti sei laureata, ma hai proseguito i tuoi studi mirando alla continuazione della ricerca e alla pratica dell’insegnamento sempre nella disciplina filosofica. Proprio per questa tua arricchita lucidità, come giudichi la tua tesi di laurea?
Si è trattato di un lavoro piuttosto impegnativo e complesso, se si considera la poliedricità degli interessi del filosofo che ho scelto di studiare e la vastità della sua produzione. Ho impiegato all’incirca nove mesi per realizzare la tesi, tra raccolta del materiale e stesura. Posso ritenermi soddisfatta perché, in relazione alle tematiche affrontate, la ricerca mi sembra sufficientemente approfondita. Sicuramente poteva essere “potenziata” la parte bibliografica, utilizzando maggiormente le considerazioni dei vari critici e mettendole a confronto tra loro; inoltre, mi sarei potuta “sbilanciare” di più nell’esprimere qualche considerazione personale. Ritengo infine che in alcune parti potevo essere più sintetica e usare uno stile più “asciutto”.
2) Chi ha scelto l’argomento della tesi e quanto e come ti ha coinvolta?
Ho avuto modo di conoscere il pensiero di Ricoeur durante il corso di filosofia politica e l’interesse che ha suscitato mi ha portato a farne oggetto della mia tesi di laurea. L’argomento mi è stato suggerito dal mio relatore: il bene oltre la giustizia e il lavoro si è concentrato soprattutto sull’opera principale del filosofo, Sé come un altro e su scritti più recenti, Il giusto I e II. Le tematiche affrontate mi hanno coinvolto molto non solo sul piano intellettuale ma anche su quello “esistenziale”. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con il tema della giustizia, con le contraddizioni del sistema penale e con i diritti, spesso calpestati, dei detenuti…Si tratta di questioni di estrema attualità se si pensa al dibattito in corso sul sovraffollamento delle carceri…ma soprattutto questa ricerca mi ha portato a riflettere sul valore inalienabile della persona e sulla necessità di difenderlo, recuperandone la portata e l’orizzonte prospettico. Proprio lo scorso anno ho avuto la possibilità di conoscere direttamente la realtà del carcere, avendo fatto, per qualche mese, la volontaria presso un istituto penitenziario e mi sono resa conto di quanto sia urgente e importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni dei carcerati e sulla funzione riabilitativa della pena per la salvaguardia dell’intero legame sociale e per il bene di tutta la comunità.
3) Vorrei che brevemente ci introducessi alla vita e alla figura di Paul Ricoeur.
Ricoeur nacque a Valence, in Francia, il 27 febbraio 1913. Orfano di padre e di madre (la mamma Florentine morì pochi giorni dopo la sua nascita e il padre Jules, professore d’inglese al liceo di Valence, cadde nel 1915 durante la prima guerra mondiale), venne cresciuto a Rennes dai nonni paterni e da una zia, insieme alla sorella Alice, più grande di lui di qualche anno, che morirà anche lei in giovane età di tubercolosi. Trascorse la giovinezza nel clima affettuoso ma al tempo stesso austero di una famiglia di solida formazione protestante. Come ricorda lui stesso: “ho dunque trascorso la mia infanzia e la mia prima adolescenza in un contesto familiare attempato, in cui la lettura occupava un posto predominante: pochi giochi, molte letture, al punto che la scuola era per me occasione di ricreazione più che di disciplina. Anche prima del rientro scolastico, e durante vacanze molto austere, in pochissimo tempo avevo assorbito tutti i libri scolastici: andare in classe era piuttosto un divertimento, e d’altronde io vi stavo in maniera molto dissipata”[1].
Maturò la sua vocazione filosofica durante gli anni di liceo a Rennes, grazie all’influenza del suo insegnante, Roland Dalbiez a cui ha attribuito il suo successivo interesse per la problematica psicoanalitica e soprattutto l’esempio di un forte senso dell’integrità intellettuale, che può essere riassunto nell’esortazione: “quando un problema vi turba, vi angoscia, vi fa paura, non tentate di aggirare l’ostacolo, ma affrontatelo di petto”. “Sono oggi persuaso – riconosce Ricoeur – di dovere al mio primo insegnante di filosofia la resistenza che opponevo contro la pretesa di immediatezza, di adeguazione e di apoditticità del Cogito cartesiano e dell’«Io» penso kantiano, mentre invece il proseguimento dei miei studi universitari mi avrebbe condotto nella movenza degli eredi francesi di questi due fondatori del pensiero moderno”[2].
Attraverso lo studio di due maestri, Lachelier e Lagneau, che ebbe modo di conoscere durante gli anni universitari, entrò in contatto con la tradizione della filosofia riflessiva francese che eserciterà una notevole influenza sulla sua speculazione successiva.
Lasciò un segno indelebile anche l’impatto con la fenomenologia di Husserl, in particolare con la traduzione inglese delle Ideen, che tradusse a sua volta dal tedesco una decina di anni più tardi e che, a suo giudizio, costituiva una risorsa preziosa per cogliere i dati originari della realtà, pur mantenendo le riserve nei confronti degli sviluppi idealistici del pensiero husserliano maturo.
Di significativa importanza infine fu l’incontro con Gabriel Marcel, che conobbe nel 1934 quando iniziò a frequentare i famosi “venerdì” durante i quali “ciascuno era invitato a trattare un soggetto scelto in comune, senza ripararsi sotto l’autorità di questo o quel filosofo illustre, e a ricorrere soltanto all’analisi sia di esperienze, comuni e enigmatiche a un tempo, quali la promessa, il sentimento di ingiustizia, sia di concetti o di categorie carichi di una lunga tradizione come l’a priori, la verità, il reale. Di questi incontri, cui presi nuovamente parte in maniera più episodica al ritorno dalla guerra, serbo un ricordo indimenticabile”[3]. I partecipanti a queste discussioni venivano iniziati al metodo socratico e a uno stile filosofico di tipo esistenziale che sollecitava l’“audacia di pensare da se stessi”. L’orientamento verso il concreto della filosofia di Marcel introdusse Ricoeur allo studio di Jaspers e contribuì ad aprire uno spazio di discussione e di approfondimento che faceva difetto alla Sorbona.
L’interesse per la fenomenologia, l’inclinazione verso il concreto e il taglio esistenziale della speculazione, rappresentati rispettivamente da Husserl, Marcel e Jaspers hanno costituito il tripode entro il quale è venuta costituendosi la carriera e l’opera personale di Ricoeur.
Non si può infine trascurare la partecipazione attiva alla vita sociale e politica del paese, attraverso la militanza ecclesiale nei movimenti giovanili protestanti e l’impegno nella sinistra socialista e pacifista.
Il suo pacifismo scaturì da un vivo senso di indignazione provato verso gli undici-dodici anni in seguito alla scoperta dell’“ingiustizia del trattato di Versailles” che lo portò a considerare la morte del padre come una “morte per niente” e si accentuò in seguito alla notizia dell’esecuzione, avvenuta negli Stati Uniti, di Sacco e Vanzetti. Questo evento gli diede l’impressione che la sua coscienza politica fosse nata proprio in quel giorno.
Coscienza che, in seguito, si tradurrà in militanza, grazie alle suggestioni di Emmanuel Mounier. Il rapporto intenso di amicizia e di collaborazione tra i due si è concentrato negli ultimi tre anni di vita del primo: dal 1947 al 1950. La riflessione di Ricoeur affonda le radici nel suolo di una antropologia filosofica connotata da quel concetto di persona a cui Mounier aveva consacrato gran parte della sua attività, proponendosi come ispiratore e animatore di una rinascita in suo favore. Da Mounier apprese inoltre ad “articolare le convinzioni spirituali con certe prese di posizione politiche”[4], estranee fino a quel momento ai suoi studi universitari e al suo impegno nei movimenti giovanili protestanti.
L’influenza di Mounier venne poi eclissata da quella di André Philip, che lo indusse a prendere parte alla campagna del Fronte popolare nel 1936, sostenendo profondamente la causa socialista. Gli sembrava infatti che la concezione dell’impegno formulata da quest’ultimo coniugasse in maniera “più franca e più netta”, rispetto a quanto aveva fatto Mounier, pensiero e azione. A ciò si aggiungeva il fatto che André Philip cercava di far collimare, in una maniera inusuale nella sinistra francese, una argomentazione teologica, fortemente impregnata dall’orientamento di Karl Barth, con il socialismo.
Tornando alla sua vita, nell’estate del 1935 conseguì con successo l’aggregazione in filosofia e, di lì a breve, sposò un’amica d’infanzia dell’ambiente protestante di Rennes, dalla quale ebbe dei figli. Inaugurò inoltre la sua vita professionale, iniziando a insegnare filosofia nei licei di Colmar e Lorient. Nei quattro anni che precedettero la guerra, proseguì la lettura di Husserl, cominciò quella di Essere e Tempo e imparò il tedesco.
La sua attività di professore agli esordi della carriera venne bruscamente interrotta dallo scoppio della seconda guerra mondiale con la chiamata alle armi e la prigionia in Pomerania durata cinque anni che, tuttavia, rappresentò un’esperienza umana estremamente significativa: insieme ad alcuni amici, tra cui Mikel Dufrenne, si dedicò ad un’intensa attività intellettuale, raccogliendo tutti i libri presenti nel campo e organizzando una sorta di università con programmi, corsi, orari, iscrizioni, esami… Si impegnò nello studio di tutte le lingue possibili: russo, cinese, ebraico, arabo…Inoltre, durante la prigionia, ebbe modo di cimentarsi nella lettura di Jaspers e in quella di Heidegger. Nello stesso tempo lavorò alla traduzione francese di Ideen I di Husserl e abbozzò una delle sue prime opere: la filosofia della volontà. Fece inoltre il giro della grande letteratura tedesca – Goethe, Schiller, oltre ad Heidegger e Husserl – e tale indagine gli permise di scoprire una certa ammirazione per il pensiero tedesco che, in qualche modo, faceva da controcanto agli eventi tragici della storia. Come scrive lui stesso, “il primo e il secondo Faust, tra gli altri, mi hanno aiutato a preservare una certa immagine dei Tedeschi e della Germania (…). La vera Germania stava là, era quella di Husserl, Jaspers”[5].
Nel dopoguerra si trasferì con la moglie e i tre figli a Chambon sur Lignon, un villaggio della Cevenne, la cui popolazione, a maggioranza protestante, durante l’occupazione nazista aveva dato riparo a tanti bambini ebrei. Là trascorse tre anni (dal 1945 al 1948) come professore di filosofia al Collège Cévenol, preparando le sue due tesi per il dottorato: il completamento della traduzione di Ideen I e Il volontario e l’involontario, pubblicato nel 1950, prima parte del progetto di una filosofia della volontà.
Nel 1948 prese ufficialmente l’avvio la sua carriera universitaria, dapprima presso la cattedra di storia della filosofia dell’Università di Strasburgo e poi, nel 1956, alla Sorbona a Parigi. Da quel momento ebbe inizio un lungo periodo di ricerca e di insegnamento suddiviso tra la Francia e gli Stati Uniti (Yale, Montréal, Columbia, poi Chicago per ventiquattro anni).
.
andrea bianchini- anni 2000

.
4) Data la complessità del tuo studio, vorrei con te cogliere alcuni nodi essenziali del pensiero del filosofo. Prima di tutto: il superamento del personalismo, del narcisismo, per il recupero della persona nella sua integralità, tra la pratica di un’intima vita spirituale e comunitaria agita nell’impegno.
“Muore il personalismo, ritorna la persona” è il titolo dell’intervento di Ricoeur a Dourdan, nel 1982, al convegno dell’associazione degli amici di Mounier, organizzato in occasione del cinquantenario della fondazione di Esprit.
Questa dichiarazione non vuole essere una critica nei confronti della portata speculativa del personalismo, è piuttosto la “registrazione di un fatto culturale”[6], la constatazione di un dato della realtà. Il personalismo come elaborazione teorica, come dottrina filosofica muore perché non abbastanza “competitivo da vincere la battaglia del concetto” [7], in quanto meno attrezzato degli altri -ismi a lui contemporanei, come l’esistenzialismo o il marxismo.
Il titolo, tuttavia, può essere letto anche come: “Muoia, muoia pure, anche se muore…, forse è meglio che muoia ecc., ciò che conta veramente è che ritorni la persona”. Quel muoia sta ad indicare che il declino del personalismo non è vissuto come un evento tragico, anzi suona quasi come un auspicio, un fatto salutare per la sua stessa identità.
Peraltro va tenuto presente che non rientra nell’essenza del personalismo misurarsi sul terreno astratto del concetto perché, come sostiene il suo fondatore, esso “è una filosofia, e non è solo un atteggiamento… è una filosofia, non è un sistema. Perché precisa delle strutture, il personalismo è una struttura e non solo un atteggiamento… Ma poiché la sua affermazione centrale è l’esistenza di persone libere e creatrici, introduce nel cuore di queste strutture un principio di imprevedibilità che sconquassa ogni volontà di sistematizzazione definitiva”[8]. È un modo di intendere l’uomo e la vita, piuttosto che una costruzione teorica e si qualifica a partire da un compito civilizzatore e da un’ispirazione di carattere spirituale ed etico-sociale. Lo stesso Ricoeur rifugge dalla tendenza a confrontare i testi di Mounier con le filosofie contemporanee, esistenzialista o marxista, poiché non si tratta di soluzioni diverse date allo stesso tipo di problemi, ma di modi diversi di interpretare i rapporti tra teoria e prassi, riflessione e azione. Possiamo quindi essere d’accordo con lui quando dice che l’apporto di Mounier al pensiero contemporaneo “è stato, piazzandosi al di sopra di una problematica filosofica in senso stretto, al di sopra delle questioni del punto di partenza, di metodo e di ordine, quello di offrire ai filosofi di professione una matrice filosofica, di proporre loro delle totalità, delle tenute teoriche e pratiche capaci di una o più sistematizzazioni filosofiche” [9].
Se come corrente in qualche modo strutturata, definita, aveva fatto il suo tempo uscendo di scena dal dibattito filosofico contemporaneo, lo stesso non può dirsi per quello che riguarda la radice speculativa che lo ha nutrito: la persona. Secondo Ricoeur, occorre “non pensare al personalismo come a qualcosa di compiuto. Del resto la vita pubblica di Mounier è stata molto breve ed egli non ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee, ma ha lasciato delle idee-guida, direttrici spirituali. Soprattutto mettendo al centro la persona, ha indicato in essa il punto di riferimento della vita politica e sociale. Per quel che egli non è riuscito a definire, facciamo noi la sua parte. Non serve certo fare dell’archeologia mounierista, perché il personalismo, io credo, è più davanti a noi che dietro. Forse il lavoro intellettuale che c’è da fare, e che anche loro fanno sul problema dell’etica e della politica e sul ruolo delle istituzioni, passa per uno sforzo di mediazione tra il segreto della vita spirituale (azione contemplativa) e il carattere pubblico dell’impegno (engagement)” [10].
“La persona ritorna” perché questo termine è ancora oggi il miglior candidato per sostenere le lotte giuridiche, politiche, sociali e culturali a favore della difesa e della promozione della dignità dell’uomo, un concetto preferenziale rispetto alle varie caratterizzazione filosofiche della soggettualità umana che hanno manifestato i loro limiti. Il progetto è il recupero della persona nella sua integralità, nel suo valore intrinseco come nella sua dimensione intersoggettiva e comunitaria, nella sua capacità di determinarsi e nella sua predisposizione a farlo, a partire dalle relazioni faccia a faccia fino ad arrivare alla complessa rete di interazioni mediata e livello sociale e politico.
Rifacendosi a Kant, Ricoeur concepisce la persona come portatrice di un valore assoluto, la cui esistenza è un fine in sé e non un mezzo di cui si possa disporre come si vuole. “La persona è una maniera di trattare l’altro e di trattare se stessi; per questo Kant formula l’imperativo: «Agisci in maniera da trattare l’umanità, nella tua persona, come nella persona di ogni altro, sempre anche come fine e mai soltanto come mezzo». L’umanità è il modo di trattare gli uomini, sia te che me. Non è né te né me, è l’ideale pratico del «Sé» in te e in me” [11].
Individua inoltre tre livelli della persona: quello metafisico, riguardante l’essere della persona in rapporto agli animali, alle cose, al posto occupato nella gerarchia degli esseri; quello etico-giuridico, riguardante le condizioni del rispetto della persona (Kant) e quello socio-politico, che riflette su quale tipo di società sia più idonea alla realizzazione della persona (Mounier). Non si può avere una cultura della persona senza avere un tipo di società, che è essa stessa pensata come persona di persone[12]. Questi tre livelli stanno a indicare la fecondità di questo concetto che può dar luogo a una riflessione metafisica, ad una di carattere etico-giuridico e ad una di carattere etico-politico e quindi adatto a porsi come punto di riferimento per una graduale umanizzazione di tutte le istituzioni della convivenza umana.
5) Narraci l’abbandono della filosofia dell’io, il decentramento dell’io, fino al riconoscersi uno fra tanti.
Il progetto di una civiltà nuova, di un nuovo Rinascimento, un combat pour l’homme legato ad una pedagogia della vita comunitaria sono i punti chiave del programma personalista che ha nutrito Ricoeur nel corso della sua indagine sul sé. Pur non avendo dedicato nessuna delle sue opere principali alla tematizzazione della nozione di persona, soprattutto nell’ultimo decennio ha rintracciato in tale categoria antropologica una chiave di lettura privilegiata della sua intera opera, auspicando il ritorno alla persona.
Per rendere effettivamente possibile e concreta l’ispirazione del progetto personalista e quindi per definire concretamente la possibilità di personalizzazione del singolo individuo e delle forme di convivenza, secondo Ricoeur, occorre rivedere il concetto stesso di “persona” e definire in modo più articolato il suo costitutivo rapporto con l’alterità a partire da un più sistematico approfondimento filosofico nella direzione ermeneutica.
In Sé come un altro, la sua opera principale, cerca di dimostrare che il sé è una realtà talmente intrisa di alterità al punto che è l’alterità stessa ad essere costitutiva del suo essere. “In un modo o nell’altro, – scrive – ho sempre saputo che l’altro non è uno dei miei oggetti di pensiero ma, come me, un soggetto di pensiero; che egli mi percepisce come un altro da sé; che insieme miriamo il mondo come una natura comune; che ancora insieme edifichiamo comunità di persone suscettibili di comportarsi a loro volta sulla scena della storia come personalità di grado superiore”[13]. Un sé che si ripiegasse su se stesso non realizzerebbe pienamente la sua costituzione di “io-altro” che lo struttura a livello ontologico e in cui consiste il suo essere più proprio e autentico. La filosofia del “sé come un altro” implica un vero e proprio progetto rivoluzionario: ritrovare il luogo della persona come quel luogo umano in cui vivono in rapporto di reciproca appartenenza identità e alterità, riscoperta del sé come riscoperta dell’altro e aprire la strada verso un recupero dell’uomo nella sua dimensione personale e comunitaria.
La caratteristica peculiare della dialettica fra sé e altro è quella di “interdire al sé di occupare il posto del fondamento”, spogliarlo della pretesa di una posizione astrattamente assolutistica di raggiungere il traguardo improbabile di una auto-trasparenza immediata e fondativa. Il punto di partenza della riflessione di Ricoeur è infatti il congedo dalle filosofie del soggetto o del cogito, in cui il soggetto è formulato alla prima persona. Dire sé è altro dal dire io. Il sé è un pronome “riflessivo onnipersonale” che si oppone all’ego chiuso in se stesso. L’io “si pone – o è deposto”[14] e “designa ogni volta soltanto una persona ad esclusione di ogni altra, quella di cui parla qui e ora”[15].
Come nota Jervolino, uno dei maggiori studiosi di Ricoeur, il sé, che da pronome relativo alla terza persona diviene onnipersonale, è una struttura che indica un’identità personale liberata dalla connessione con il mio io individuale, cioè “una soggettività plurale e declinabile”. Più precisamente: “l’esser se stessi, l’ipseità, non appartiene a qualcuno in modo particolare, ma è una dimensione che tutti ci accomuna, restando ciascuno quel singolo insostituibile che è, in fondo tale dimensione coincide con quella della persona…; ma all’intuizione e all’ispirazione personalistica (di E. Mounier) il nostro autore fornisce l’apporto di un incomparabile rigore fenomenologico ed analitico”[16].
L’altro da sé si presenta dunque come qualcosa di inviolabile e di intangibile, che non può essere ridotto ad un paradigma precostituito e che si sottrae a qualsiasi tentativo di sopprimere la differenza, la diversità che ne contraddistingue la struttura. Non può essere dominato, né dominare, perché sopraggiunge in maniera del tutto improvvisa.
L’apertura all’altro ha dunque bisogno di una graduale presa di distanza da sé stessi: solo lavorando sullo spadroneggiare dell’io che porta a considerare l’altro come un alter ego, come una replica di se stessi, tale apertura diviene effettivamente possibile. Senza il lavoro sul proprio narcisismo, l’altro diviene il prodotto delle proiezioni psicologiche dell’io, oppure viene abbassato a semplice strumento.
Questa operazione però non deve provocare il misconoscimento o la mortificazione di sé, ma deve condurre ad una equilibrata stima di sé che salva l’identità di ciascuno dei termini coinvolti e consente un adeguato riconoscimento dell’altro. All’operazione di spossessamento deve quindi seguire un movimento di “riappropriazione di sé”. Riappropriazione che non è mai definitiva e compiuta, ma possibile solamente riconoscendo l’altro e lasciandosi istruire da esso. L’acquisizione profonda di questo movimento di spossessamento e di riconquista è l’accettazione consapevole e responsabile di noi stessi e dell’altro che è in noi.
Il sé come soggetto decentrato, come soggetto altro dal soggetto autofondantesi della tradizione filosofica, come sé che si ritrova altro, diventa uno qualsiasi dei tanti esseri umani che agiscono e che soffrono. Accettare se stessi e riconoscersi come uno fra tanti, oltre ogni strategia di spossessamento, sembra essere la posta in gioco più essenziale dell’ermeneutica del sé.
.
andrea bianchini- verso la luce

.
6) Un altro punto fondamentale, secondo me, è il legame di appartenenza e di responsabilità dell’io verso la comunità, contribuendo alla costruzione di una realtà sociale da migliorare.
Riferendosi all’ispirazione personalista, Ricouer ritiene che l’uomo diventa persona, realizzando appieno la sua natura, nella misura in cui instaura un rapporto umano, una comunicazione dialogante con gli altri uomini, con i quali intreccia una molteplicità di relazioni: da quelle faccia a faccia fino ad arrivare alla complessa rete di interazioni mediate a livello sociale e politico. Non si può avere la piena determinazione della propria identità se non si è riconosciuti dagli altri e non è da soli che si diventa persone: si diventa tali nel momento in cui la richiesta di essere riconosciuto riceve una risposta positiva.
Il darsi dell’alterità e della sua relazione con la soggettività è dunque fondato sul riconoscimento di una originaria affinità tra gli uomini tale per cui l’altro, in quanto mio simile, è sempre legittimamente oggetto della mia “spontaneità benevola”, anche quando, nell’effettivo darsi della molteplicità fenomenica, si instaurano relazioni asimmetriche con coloro che mi sono ignoti e sconosciuti e con i quali condivido solo l’appartenenza formale ad una rete di relazioni istituzionalmente mediate.
Il passaggio al livello delle istituzioni si rivela necessario perché il piano delle relazioni interpersonali non è sufficiente al pieno dispiegamento della persona. Se “il prossimo è il modo personale in cui io incontro l’altro, al di là di ogni mediazione sociale”[17], il “socius è colui che io raggiungo attraverso la sua funzione sociale; la relazione con il socius è una relazione mediata; essa tocca l’uomo in quanto…”[18]. È la figura che rappresenta il mondo nel quale viviamo ed è l’espressione di “un tipo di rapporti umani sempre più estesi, sempre più complessi e sempre più astratti”[19]. L’altro come “socio” è colui che non può essere oggetto o destinatario del mio sentimento di amicizia o del mio amore, perché non condivide con me alcuna relazione affettiva. Appartiene alla mia stessa realtà sociale e politica e, come me, gode degli stessi diritti e si riconosce nella stessa legge e negli stessi obblighi di fronte ad essa: è impegnato in ruoli che, seppure non sempre necessariamente equivalenti, si integrano a formare un unico corpo sociale e politico. In questo spazio emergono forme di interazione che si sviluppano in modo prevalentemente formale e impersonale, perché organizzate e mediate da strutture istituzionali. Tali strutture, sia nella forma del diritto che in quella degli apparati statali e burocratici, si preoccupano di assicurare l’uguaglianza dei cittadini all’interno dei rispettivi ruoli e la reciprocità di ciascuno in merito ai diritti e ai doveri previsti dalla legge stessa, ma a partire dal principio dell’anonimità, quindi a prescindere dalla significazione affettiva e dall’accento posto sulla differenza e l’unicità che invece caratterizza i rapporti personali e privati.
Il “socio” o “terzo”, tuttavia, pur essendo destinato a restare senza volto, non è privo di una significazione etica o non degno della mia sollecitudine. Il piano delle istituzioni, pertanto, attesta la possibilità di una reciprocità mutua, che si dispiega dal “tu” al “ciascuno” e che permette di “toccare con mano” le molteplici sfaccettature dei rapporti interumani, fino a includere tutti coloro che il faccia a faccia esclude. Anzi, attesta la possibilità che la relazione possa dar conto di un terzo escluso dalla “prossimità”, ma incluso nella reciprocità dell’etica ternaria: tendere alla vita buona, con e per gli altri, all’interno di istituzioni giuste.
Il riconoscimento, dunque, non si limita ai legami che si stabiliscono nella “prossimità” ma si estende a tutte le forme in cui l’esistenza umana si manifesta. In virtù di questo riconoscimento reciproco, i soggetti coinvolti nella relazione possono donarsi gli uni agli altri e fare esperienza dell’intima capacità dell’uomo di accogliere l’alterità. Soltanto quando anche il lontano sarà diventato prossimo, il processo di personalizzazione a cui l’uomo è chiamato in virtù del suo statuto originario potrà giungere a compimento e le relazioni tra le persone potranno dispiegare appieno le loro potenzialità.
Declinando l’alterità alla maniera del “prossimo” e del “socio”, si dà voce alla ricchezza di significati a cui essa può giungere e si legittima l’uguale diritto di ciascuno ad essere riconosciuto come persona. In virtù della similitudine e della reciprocità, il diritto al “farsi persona” può essere attribuito a tutti i propri simili, operando affinché anche loro possano realizzarsi pienamente. In questo senso, la diversità di religione, cultura, razza, provenienza…che mi distingue dall’altro non si traduce automaticamente nell’impossibilità di trovare un punto di incontro ma si configura piuttosto come l’occasione per scoprirsi membri di una stessa realtà sociale e politica e costruttori di una società nella quale le differenze, anche quelle apparentemente inconciliabili, possano essere difese e integrate.
Punto di mediazione e di incontro fra le due possibili modalità di relazione è la persona, nella quale si saldano momento interpersonale e momento istituzionale, l’uno e l’altro ugualmente necessari alla dinamica della vita personale. “La relazione interpersonale profonda è certamente il vertice della relazione ma, nella generalità dei rapporti fra gli uomini, rappresenta non la regola ma l’eccezione. La norma dei rapporti umani è la mediazione, solo apparentemente «esteriore» della politica”[20].
7) Ricoeur “si è molto interrogato sul tema della giustizia, sul paradosso di una giustizia che sembra cedere alla forza, sul tema del perdono e sul difficile legame con l’amore e sulla possibilità di una giustizia non violenta e riabilitativa”. Illumina essenzialmente le sue prospettive di pensiero.
Ricoeur ha riflettuto sulla giustizia nel suo rapporto strutturale al bene e ha concentrato la sua attenzione sul paradosso della pena, mettendo in evidenza che la sofferenza inflitta dalla punizione al colpevole condannato è un vero e proprio scandalo perché forse ristabilisce l’ordine ma, rispondendo al male con il male, non garantisce alcuna redenzione. È questo il motivo per cui, secondo il filosofo, risulta impossibile trovare delle ragioni che rendano accettabile che alla violenza illegale del delitto si aggiunga una seconda violenza legale, quale la pena. Ciò che fa scalpore è il fatto che difficilmente la punizione può essere accettata dal colpevole se si considerano le pratiche correnti del sistema penale. Non per via della legalità della punizione, ma per via della facilità con cui le forme della legalità degenerano in violenza sul condannato. Occorre quindi distinguere tra la funzione e la credibilità dell’apparato penale da un lato e la critica della pratica legale nei casi in cui degenera in abuso.
La finalità dell’atto di giudicare è, nel breve termine, quella di porre fine ad una situazione di conflitto, tracciando una linea di separazione tra le parti contendenti volta a “delimitare le pretese dell’uno e le pretese dell’altro”[21]. Tuttavia, la giustizia non può limitarsi a questo. Lo scopo ultimo non è punire ma riparare e riconciliare. Se la comminazione della pena non può essere eliminata, di fatto occorre puntare l’attenzione sulla riabilitazione come finalità intrinseca al provvedimento stesso che consenta la ricostruzione del legame organico che tiene insieme una comunità umana e la riabilitazione di ciascuno dei componenti del triangolo della pena: si deve ricostruire la legge, si deve offrire soddisfazione alla vittima e ci si deve fare carico del colpevole. Deve quindi attuarsi una giustizia che, attraverso l’ascolto e il colloquio, miri meno a riparare il passato e più a responsabilizzare e a prevenire in vista del futuro.
Risulta chiaro che la soluzione del paradosso denunciato non può essere una risposta razionale, ma solamente una speranza: l’“utopia di una giustizia non violenta”, in cui l’uso della parola veicoli esperienze alternative volte a educare piuttosto che a reprimere. Il valore della parola risiede nella capacità di elaborare il conflitto in direzione di un’autentica “vittoria della parola sulla violenza”, con il proposito di umanizzare l’insopprimibile istinto di vendetta insito nella natura umana.
Perché questo possa accadere, si deve permettere al perdono di operare grazie a un gesto di riconciliazione che interrompe la spirale dell’odio e crea le condizioni per uno spazio di rigenerazione che risulta possibile perché il male è “radicale”, ma non “originario”. Originaria nell’uomo è la disposizione al bene, mentre l’inclinazione al male viene contratta storicamente e costituisce un semplice fatto o accidente.
Il “progetto” del perdono non è cancellare la memoria, non è l’oblio perché quello che è accaduto non può essere rimosso; al contrario, alla base, c’è la volontà di instaurare un rapporto nuovo, di ristabilire una relazione su presupposti diversi da quelli precedenti, operando una sorta di guarigione della memoria e considerando che la persona vale in ogni caso più delle sue azione e delle sue colpe. Il contenuto del perdono è un nuovo progetto di vita, una nuova forma di convivenza, un impegno morale volto a far sì che ciò che è stato non si ripeta. Ricoeur suggerisce l’uso critico della memoria, l’importanza di narrare diversamente il passato che si realizza nel ricordare-raccontando, nel raffigurare altrimenti, talvolta anche dal punto di vista dell’avversario.
Le istituzioni pubbliche, in modo particolare gli organismi giuridici, sembrano non assegnare alcun ruolo positivo al perdono. Esse infatti si reggono su una logica di equivalenza, quella tra il crimine e la punizione, nella quale sembra non esservi spazio per il carattere “non soltanto sovra-giuridico ma anche sovra-etico” del perdono dettato dalla logica di sovrabbondanza che lo articola. Il funzionamento della giustizia si basa sull’idea che il processo, il dibattimento e i diversi gradi di giudizio sono istituti volti a perseguire due obiettivi: la sostituzione del conflitto violento con il conflitto verbale, ossia la sospensione della catena criminale attraverso il ricorso alla dialettica tra le parti e la ricerca di un racconto coerente dei fatti, ossia la ricostruzione di un passato il più possibile condiviso dai soggetti coinvolti.
A partire da queste considerazioni, Ricoeur mette in luce l’opposizione esistente tra il comandamento d’amore e la Regola d’oro, il primo dei quali rispondente a una logica paradossale del dono e della sovrabbondanza, la seconda, che sta alla base dell’idea di giustizia distributiva, fondata sulla reciprocità e l’uguaglianza.
Da una parte, le sue analisi si concentrano sul paradossale comandamento evangelico di amare i propri nemici, che è espressione dell’amore assoluto e gratuito di Dio per gli uomini: se Dio ama l’uomo tanto da donargli non solo la vita e il creato, ma anche se stesso, anche l’uomo è chiamato a collocarsi nella stessa economia del dono amando coloro che lo perseguitano. La giustizia, invece, si basa sulla logica dell’equivalenza che vede incarnata nella Regola d’Oro. Contrariamente a quello che avviene nella sfera dell’amore, nella giustizia non si ha il mutuo riconoscimento. L’ambito giuridico-istituzionale è il regno impersonale del chiunque che esige solamente l’uguaglianza di fronte alla legge. Prevede infatti che sia dato a ciascuno secondo un principio di equa distribuzione e mira perciò ad equiparare i comportamenti, ma non tiene conto delle intenzioni. Concerne la sfera dell’esteriorità in cui gli uomini appaiono estranei l’uno all’altro. In altri termini, “l’amore rende singolo, mentre la giustizia universalizza. Ho degli obblighi di giustizia nei confronti di chiunque – scrive Ricoeur – dove la nozione di chiunque è assolutamente importante; è il livello della legge, nel quale la giustizia riguarda ogni relazione umana. Devo essere giusto nei confronti di tutti poiché posso amare in modo personale pochissime persone. In questo senso si può dire che la giustizia universale danneggia l’amore e che l’amore rende singolo”[22].
Fra la logica del dono, che è propria dell’amore, e la logica dell’equivalenza, che è propria della giustizia, il filosofo cerca di rintracciare una dialettica nella quale l’amore riconosce le ragioni della giustizia, ma le trascende nella sua sovrabbondante generosità. Le due logiche, lasciate a se stesse, rischiano di dare luogo a una serie di possibili perverse interpretazioni, nel momento in cui si trasformano in principi d’azione a senso unico: come potrebbe diventare regola d’azione una norma che impone di porgere continuamente l’altra guancia, e di non rifiutare il mantello a chi si impossessa della tunica, sancendo così la prevaricazione di alcuni soggetti su altri? E ancora, se il comandamento d’amore abolisse la regola d’oro di giustizia, che tipo di distribuzione potrebbe mai venire istituita qualora la massima di offrire senza nulla attendere in cambio fosse eretta a principio universale? La dissimmetria assoluta dell’amore gratuito deve in qualche modo passare attraverso il principio di moralità e di reciprocità della Regola d’Oro, per potersi incarnare nella vita sociale. La Regola d’Oro, a sua volta, deve elevarsi alla logica della sovrabbondanza, e lasciarsi da essa ispirare e correggere, per trasformare il calcolo in cooperazione. In questo senso, il Comandamento d’amore non abolisce né annulla la Regola Aurea, bensì la orienta nel senso e nel segno della generosità e della partecipazione disinteressata e la salva da un’interpretazione sempre possibile nei termini di legge del taglione.
8) Mi interessa molto il concetto di distribuzione non soltanto relativa al significato economico.
La posizione centrale che la nozione di giustizia distributiva occupa nell’interpretazione ricoeuriana di Aristotele influenza in maniera determinante il suo modo di concepire l’istituzione, al punto che la società viene teorizzata come un sistema di distribuzione. Per Aristotele, la forma più alta di giustizia è quella distributiva. Essa consiste in una uguaglianza proporzionale: la ripartizione di beni che la polis effettua tra i cittadini – cariche pubbliche, riconoscimenti onorifici, benefici economici di vario genere – deve avvenire in maniera proporzionale al merito di chi la riceve, in base cioè al contributo che ciascuno apporta alla produzione dei beni stessi.
Secondo Ricoeur, la funzione principale delle istituzioni, in quanto espressione del legame e della struttura sociale, è quella di assicurare una suddivisione equa di ruoli e insieme garantire coesione e durata al “voler vivere insieme”. Ciò significa che le istituzioni e tutte le strutture che provvedono a regolare e organizzare la convivenza civile sono sostenute da un’idea di giustizia distributiva, che esprime e traduce al loro interno quella ricerca di uguaglianza che muove la naturale sollecitudine dell’uomo verso l’altro da sé e che costituisce il fondamento della socialità. La mediazione istituzionale, dunque, interviene alla maniera di una “regola di distribuzione” nella misura in cui ripartisce sia i beni commerciali, quali rimunerazioni, patrimoni, risorse finanziarie, sia i beni non commerciali, quali sicurezza, salute, educazione, cittadinanza…ma anche posti di autorità e di comando. Ricoeur osserva come la dimensione istituzionale sia in un certo senso indispensabile al concetto di giustizia, perché è quasi sempre in rapporto a beni esteriori e precari, o in relazione alla prosperità e all’avversità che si pone la questione del giusto o dell’ingiusto. Questi sono in genere dei beni o dei mali da spartire e tale divisione avviene attraverso l’istituzione secondo la formula: suum cuique tribuere.
Quanto detto consente di comprendere il passaggio dal livello interpersonale a quello istituzionale. “L’istituzione, in quanto regolatrice della distribuzione di ruoli, dunque in quanto sistema, è molto di più e altra cosa rispetto agli individui che ricoprono i ruoli”[23] ma, d’altra parte, “esiste soltanto in quanto gli individui vi prendono parte”[24]. È un supporto formale, una mediazione efficace che favorisce l’affermazione delle libertà particolari e permette di vincolare e raccogliere in una comunità coesa una molteplicità di individui altrimenti estranei tra di loro e privi di una identità comune.
Consente, inoltre, il ripensamento delle modalità di interazione tra le persone soprattutto in merito al carattere della asimmetria e alla relazione con il terzo. L’asimmetria è un tratto costitutivo della relazionalità umana, “le forme di relazione personale, infatti, sia come rapporti personali privati basati su significati affettivi, sia come interazioni pubbliche oggettivamente mediate e istituzionalizzate non si realizzano sempre e soltanto sotto il segno della reciprocità, come rapporto paritario tra soggetti distinti ma equivalenti, che intrecciano le loro relazioni nella forma di una perfetta corrispondenza biunivoca”[25]. Tuttavia, anche laddove i termini della relazione sfuggono alla logica dell’equivalenza e non riposano su un medesimo piano condiviso, è possibile mediare la distanza e dare vita a una relazione di autentica condivisione, nella quale le prerogative di entrambi i termini vengono reciprocamente riconosciute.
Nelle istituzioni, considerate come regola di distribuzione, gli individui sono partners: essi prendono parte nella misura in cui la società assegna a ciascuno degli incarichi. “La società politica, infatti, è costituita da una molteplicità di soggetti che non solo ne fanno parte, ma ne prendono parte, poiché appartenere ad una società significa non solo riconoscersi e definirsi al suo interno in relazione reciproca con gli altri membri in un comune senso di appartenenza e di cittadinanza, ma anche rendersi disponibili, in un atteggiamento di cooperazione, ad una equa ripartizione dei privilegi e degli oneri che l’essere cittadino comporta”[26].
L’interpretazione distributiva dell’istituzione, infine, contribuisce ad abbattere il muro invisibile che contrappone l’individuo e la società e assicura la coesione tra la componente individuale, interpersonale e societaria della vita etica. Ricoeur sostiene che “il senso finale delle istituzioni è il servizio reso alle persone; se non c’è nessuno che ne trae profitto e crescita, esse sono vane”[27]. Questa è la loro vocazione. Quella del diritto, e in generale delle istituzioni, è una funzione in qualche modo propedeutica all’instaurarsi di relazioni interpersonali profonde. Non è nell’ambito dello Stato che il rapporto “io-tu” si esprime in tutte le sue dimensioni; anzi esso rappresenta “un caso estremo”, reso tuttavia possibile dalla funzione di garanzia dei diritti individuali assicurati dalle istituzioni. Il loro ruolo è quello di rispettare e promuovere l’uomo apparentemente senza volto, ma che, proprio attraverso l’attuazione della giustizia, finisce per assumerne uno, grazie al meccanismo del riconoscimento; un riconoscimento che, sul piano delle istituzioni, è all’inizio soltanto giuridico e sociale, ma che è la condizione preliminare e indispensabile perché alla fine questo iniziale “io anonimo” possa diventare, nella relazione con l’altro, “io personale”.
.
andrea bianchini- positivo/negativo

9) La personalità filosofica di Ricoeur imprime energia. Pur leggendo con nitore, senza retoriche, l’interiorità e l’esterno dell’io, rifonda le potenzialità delle proprie capacità per intervenire nel tessuto civile e nella relazione. Quanto questo pensiero laico ha una matrice cristiana?
Ricoeur non ha mai fatto mistero della sua appartenenza al protestantesimo. Ha dichiarato di essere cresciuto in un ambiente fortemente impregnato dalla lettura della Bibbia che lo ha abituato ad una “frequentazione” quotidiana con le Scritture. L’accettazione senza reticenze dell’educazione protestante lo ha condotto a sviluppare un “sentimento di dipendenza assoluta” verso la dimensione religiosa, in virtù del quale la convinzione che la parola dell’uomo sia preceduta dalla “Parola di Dio” risultava più forte del senso di colpa o delle nozioni di peccato e di perdono.
Ben presto si è trovato nella condizione di dover mediare la propria convinzione con una serie di dubbi intellettuali emersi nel corso degli studi universitari, che ha definito come “linea critica” della filosofia. “Servo un vivo ricordo – scrive – di un episodio acuto di questo conflitto interiore. Esso è legato alla scoperta de Le due fonti della morale e dalla religione di Bergson, apparso quando terminavo la mia licenza di filosofia, e della teologia di Karl Barth, veicolata dai movimenti giovanili protestanti (più tardi, credo, lessi Das Wort Gottes und die Theologie e il primo commentario della famosa Epistola ai Romani)”[28]. Il conflitto era, dunque, tra una filosofia religiosa di stampo bergsoniano e il radicalismo barthiano che cominciava a segnare il protestantesimo francese, orientandolo verso un ritorno radicale e antifilosofico al testo biblico.
Come lui stesso ha dichiarato, per tutto il corso della sua vita si è mosso intorno a questi due poli: uno biblico e uno razionale e critico e ha espresso questo atteggiamento attraverso la dialettica fra critica e convinzione: “l’atteggiamento critico starà piuttosto sul versante filosofico, poiché il momento religioso in quanto tale non è un momento critico; è un momento di adesione a una parola, che si ritiene venire da più lungi e da più in alto rispetto a me, e questo, in una lettura kerigmatica, confessante. A questo livello si trova, dunque, l’idea di una dipendenza o di una sottomissione a una parola antecedente, contrariamente alla sfera filosofica (…). L’aspetto, che mi sembra costitutivo del religioso, quindi, sta nel far credito a una parola secondo un certo codice, nei limiti di un certo canone”[29].
Nei confronti delle due sfere, ha sempre vissuto “una sorta di duplice sudditanza” che, nell’evolvere della sua riflessione, ha assunto orientamenti diversi.
In un primo momento ha dichiarato una “sorta di divieto di soggiorno di Dio in filosofia” e ha rifiutato qualsiasi speculazione di carattere ontoteologico. Nelle ultime pagine di Sé come un altro ha lambito il religioso parlando della voce della coscienza ma, al tempo stesso, ha fatto una dichiarazione di agnosticismo affermando che, in qualità di filosofo, non poteva dire se si trattasse della voce degli antenati, del testamento di un dio morto o di un dio vivente. Si è arrestato dunque nel tentativo di specificare a chi appartenga la voce che ingiunge. Ci teneva inoltre a evitare qualsiasi commistione tra dimensione del filosofico e dimensione del religioso per rivendicare l’autonomia del suo insegnamento e sottrarsi al rischio di essere accusato “periodicamente di essere un teologo mascherato che filosofeggia, o un filosofo che fa pensare o lascia pensare il religioso”[30].
Successivamente, pur non arrivando mai a “fare un amalgama qualsiasi tra la filosofia e la fede biblica”, è giunto a stemperare questa separazione così netta tra “filosofia senza assoluto” e “fede biblica” e a realizzare “una sorta di armistizio” quando, impegnato nella comprensione del soggetto alla ricerca di sé, ha proposto una distinzione fra l’argomentazione filosofica, che si situa nello spazio pubblico della discussione, e le motivazioni profonde che stanno alla base del suo impegno filosofico e della sua esistenza personale e comunitaria e che non possono essere padroneggiate ma solo ricevute. “Ho sempre avuto confidenza – scrive – in un fondo di interpellanza che, in definitiva, è più resistente, più profondo e che viene più da lontano rispetto alla stessa critica. La critica, comunque, è sempre articolata a partire da poteri che io domino, mentre questa donazione di senso mi sembra che mi costituisca sia come soggetto ricevente che come soggetto critico. La polarità dell’adesione e della critica è, essa stessa, all’insegna di questa donazione anteriore”[31].
Ricoeur sostiene che, pur avendo registri differenti, ragione e fede possono trovare dei punti di intersezione. In questa fase, dunque, si dimostra maggiormente disponibile a prendere in considerazione i problemi posti dalle interferenze e dagli sconfinamenti del religioso e del filosofico, andando al di là di quella che lui definisce “schizofrenia controllata” e lasciando che a parlare sia l’uomo e la sua vita, piuttosto che l’autore e il suo pensiero. Un esempio significativo di intersezione del registro del morale filosofico con quello religioso è rappresentato dalle riflessioni sull’“economia del dono” e sulla “logica della sovrabbondanza”.
10) Puoi indicare di tutta la bibliografia di Ricoeur il libro più pregnante? E perché lo ritieni tale?
Sé come un altro (1990) è l’opera nella quale si trova, per così dire, “ricapitolato” l’itinerario filosofico di Ricoeur e nella quale le molteplici sfaccettature della sua speculazione si riannodano intorno all’indagine sul sé. Il lavoro è venuto alla luce in seguito alla rielaborazione delle Gifford Lectures svolte ad Edinburgo nel 1986 quando gli era stato chiesto di presentare una sintesi dei suoi lavori. Impresa ardua, come riconosce lui stesso, se si considera che si trattava di rintracciare un filo conduttore in un percorso filosofico sviluppatosi nell’arco di un quarantennio e caratterizzato da una pluralità di questioni determinate e apparentemente distanti tra loro: il volontario e l’involontario, la finitudine e il male, le implicazioni filosofiche della psicoanalisi, l’innovazione semantica che è all’opera nella metafora viva, la struttura linguistica del racconto, la riflessività e i suoi stadi, il tempo…Ricoeur ha dichiarato di essere spinto dai residui, da ciò che ogni lavoro, giunto al suo termine, lascia in sospeso e che fornisce lo spunto dal quale prendere l’avvio per il successivo soggetto da trattare. Di qui l’andamento “locale” della sua opera, vale a dire una philosophie du détours, segnata da continue deviazioni e digressioni attraverso le molteplici obiettivazioni del sapere filosofico.
Sono tre le principali intenzioni filosofiche sottese a Sé come un altro. La prima sottolinea “il primato della mediazione riflessiva sulla posizione immediata del soggetto quale si esprime alla prima persona singolare: «io penso», «io sono»”[32]. Soi, come l’inglese self, il tedesco Selbst, l’italiano sé, lo spagnolo simismo, si oppone a je, I ecc… Ricoeur sottolinea il proprio uso di soi in un contesto filosofico, oltre la definizione grammaticale che ne fa un pronome riflessivo di terza persona, come pronome riflessivo appartenente a tutte le persone grammaticali.
La seconda prospettiva, implicitamente contenuta nell’ambiguità del titolo sotto il termine “même”, “consiste nel dissociare le due principali significazioni dell’identità a seconda che intendiamo per identico l’equivalente dell’idem o dell’ipse latino”[33]. L’ambiguità del termine identico è dovuta al fatto che non esistono in francese due vocaboli distinti per medesimo e stesso. Tale equivocità costituisce il presupposto intorno al quale viene a dispiegarsi la trattazione di Ricoeur sull’identità personale e l’identità narrativa in merito ad una delle principali caratteristiche del sé: la sua temporalità. Sono queste le coordinate essenziali dell’antropologia etica di Ricoeur.
La terza prospettiva dispiegata dal titolo stesso dell’opera sottolinea come “l’identità-ipse metta in gioco una dialettica che risulta complementare a quella dell’ipseità e della medesimezza e cioè la dialettica del sé e dell’altro da sé”[34]. Come sottolinea l’Autore, “il nostro titolo suggerisce un’alterità che non è – o che non è soltanto – un termine di paragone, un’alterità quindi che possa essere costitutiva dell’ipseità stessa. Sé come un altro suggerisce fin dall’inizio che l’ipseità del se stesso implica l’alterità ad un grado così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’altra, che l’una passa piuttosto nell’altra – come diremmo in linguaggio hegeliano. Al «come» vorremmo annettere la significazione forte, legata non soltanto ad una comparazione – se stesso somigliante ad un altro -, ma ad una implicanza: sé in quanto… altro”[35].
La meta essenziale di Sé come un altro consiste nel mostrare i caratteri e la costituzione piena del mistero della persona, la cui difficile e, per certi aspetti, imperscrutabile identità non si lascia definire nelle dialettiche idem–ipse ed ipseità–alterità, anche se queste ne manifestano frammenti essenziali e significativi.
Il programma di Ricoeur si snoda attraverso due fasi successive:
– la polemica contro le filosofie del soggetto o del cogito, delle quali è paradigmatico il fatto che il soggetto sia formulato alla prima persona – ego cogito -, “sia che l’«io» si definisca come io empirico o come io trascendentale, sia che l’«io» sia posto assolutamente, cioè senza altro corrispettivo, o relativamente, nella misura in cui l’egologia postula il complemento intrinseco dell’intersoggettività”[36];
– il recupero del sé attraverso successivi livelli di approfondimento e di implicazioni (esperienziali, linguistiche, etico-morali ed infine ontologiche). I quattro piani di quella che si potrebbe chiamare una fenomenologia ermeneutica della persona (o fenomenologia ermeneutica del sé) sono il linguaggio, l’azione, il racconto, la vita etica o, detto in altri termini: il soggetto (je) come agente di discorso e di azione, come narratore e protagonista del suo racconto di vita attraverso la mediazione narrativa e, infine, il soggetto responsabile, centro dell’etica.
Rispetto alle filosofie del soggetto in prima persona, il nuovo paradigma dell’ermeneutica del sé si fa una domanda sull’identità di quell’esser se stessi che noi siamo nel rapporto costitutivo con l’altro. Egli costruisce pazientemente le diverse tappe del discorso sul sé, proponendo successivamente le diverse domande che ruotano intorno all’interrogativo “chi?”: “chi parla? chi agisce? chi si racconta? chi è il soggetto morale d’imputazione?”[37]. Ogni volta la risposta è “il sé”. Il soggetto ricoeuriano è il soggetto che si interroga su chi sia quel sé che parla, che compie l’azione o la patisce, che è il personaggio del racconto, che è responsabile dell’azione dal punto di vista del bene e dell’obbligazione morale, che declina questa domanda che gravita attorno alla questione sull’identità personale per tutte le persone e che sa che l’altro che “come me, dice «io»”[38] deve potersi porre la stessa domanda.
La molteplicità delle domande dà vita a quattro sottoinsiemi che conferiscono un ordine agli studi di cui si compone l’opera, delineando un percorso che va dalla filosofia del linguaggio alla filosofia dell’azione, dalla teoria del racconto all’etica. L’ordine dei sottoinsiemi segue la progressione fra descrivere, narrare, prescrivere. La teoria narrativa opera una vera e propria mediazione fra il punto di vista descrittivo sull’azione e il punto di vista prescrittivo poiché “l’ampliamento del campo pratico e l’anticipazione delle considerazioni etiche vengono implicate nella struttura stessa dell’arte del raccontare”[39].
L’Autore ci offre una strada lunga che passa per il confronto con il dibattito filosofico contemporaneo (sul duplice versante “analitico” e “continentale”) e con i grandi pensatori della tradizione filosofica. La deviazione della riflessione attraverso l’analisi fonda “un’alleanza nuova tra la tradizione analitica e la tradizione fenomenologica ed ermeneutica”[40], tale nuova alleanza permette alla questione del sé, nel suo riguadagnare terreno rispetto alla semantica e alla pragmatica dell’azione, di prospettare delle “rielaborazioni considerevoli sul piano stesso dell’agire umano”[41]. Scrive Ricoeur: “Tutta la massa delle analisi del linguaggio e dell’azione, di cui avevo un tempo cercato una prima approssimazione nella semiotica strutturale, e di cui la filosofia analitica di lingua inglese mi proponeva dei campioni mirabilmente elaborati, veniva, così, a trovarsi integrata alla grande tradizione riflessiva. Il mio primo disegno, allora, fu quello di incorporare quanto avevo improntato alla filosofia analitica del discorso ordinario a una ermeneutica del soggetto parlante e agente”[42].
Merita un’attenzione particolare la questione che il filosofo affronta nei capitoli centrali dell’opera quando si chiede: “chi è il soggetto morale di imputazione?”, sviluppando quella che ha definito “piccola etica”. Le problematiche etico-morali, infatti, riassumono e concludono le ricerche precedenti, poste sotto il segno dell’indagine antropologica – ovvero il progetto ricoeuriano volto al recupero del soggetto -, ma insieme consentono di intravedere uno sbocco, in quanto la focalizzazione dell’individuo etico dischiude la prospettiva di un prolungamento della riflessione intorno ai rapporti fra etica e politica.
L’argomentazione ruota intorno al concetto di imputabilità che si colloca come punto di articolazione fra piano narrativo e piano etico e viene intesa come capacità dell’essere umano di render conto, a se stesso e agli altri, delle proprie azioni, assumendosene la responsabilità in qualità di loro vero autore. Soltanto quelle azioni la cui causalità può essere imputata a soggetti responsabili possono essere qualificate moralmente come permesse o vietate, buone o cattive, giuste o ingiuste.
A sua volta, tale tema dell’imputabilità ha consentito a Ricoeur di sviluppare un’articolazione interna tra l’etica fondamentale che governa il desiderio di una vita compiuta, la morale dell’obbligazione con il suo sistema articolato e storicamente determinato di norme universali, imposte per far fronte alle situazioni di conflitto e di violenza e la “mediazione imperfetta” e fallibile che etica e morale trovano nella “convinzione” di quella saggezza pratica che ridefinisce l’obbligazione morale e il suo orizzonte di felicità nelle sfere pratiche distinte. Qui si tratta di prendere decisioni in situazioni singolari di incertezza, di conflitto e di rischio e di passare dal livello astratto dell’obbligazione a quello concreto della saggezza pratica, in cui si esplica il giudizio morale in situazione. Ne sono un esempio la sfera dell’arte medica, quella della giustizia, quella della storiografia, quella del giudizio politico…
Tematiche, queste ultime, di cui Ricoeur si è occupato nell’ultima fase della sua attività intellettuale, a dimostrazione che Sé come un altro non è un testo conclusivo ma apre a tutta una serie di approfondimenti concernenti le problematiche dell’etica applicata, che sono stati sviluppati attraverso il confronto con giuristi, medici, psichiatri, e dai quali sono scaturiti testi più recenti come: il giusto, la natura e la regola…
.
andrea bianchini- l’acchiappasogni
.
11) Nella nostra società decadente, affogata da vertigini consumistiche e crisi economiche e culturali, ritieni che la filosofia sia una pratica di pensiero obsoleta o necessaria?
Contrariamente a quanto si pensa, la filosofia non è qualcosa di astratto che parla con un linguaggio esoterico, ma si configura piuttosto come una dimensione che ha a che fare con la natura più propria dell’uomo, in quanto nasce dal suo essere razionale e, come dice Aristotele, dalla sua tensione naturale verso il sapere che lo spinge a interrogarsi incessantemente su tutto ciò che lo circonda. Come tale, è qualcosa che interessa e coinvolge l’essere umano nella sua totalità perché mette in discussione il suo stesso stare al mondo.
Lo “stile” che caratterizza il “fare filosofia” è la conversazione, lo scambio di opinioni, il dialogo. Quest’ultimo si configura come discussione strutturata intorno a domande e risposte tra persone unite dal comune interesse per la ricerca. Dialogare non significa accettare semplicemente che esistano altri punti di vista o altri indirizzi di ricerca ma vuol dire, piuttosto, accoglierli con la volontà di intenderli nelle loro ragioni, riconoscendogli la stessa legittimità che si attribuisce ai propri. In questo senso la “pratica” della filosofia può condurre a una visione polimorfa della realtà, perché educa alla presa in carico di una pluralità di prospettive e contribuisce a cogliere la storicità delle posizioni.
Questa abitudine a pensare risulta particolarmente urgente nel panorama attuale, così complesso e frammentato, per favorire una riflessione unitaria che vada oltre il mero dato o la semplice analisi e consenta di individuare quell’orizzonte di senso entro il quale si gioca l’esistenza di ciascuno. Credo infatti che attraverso la riflessione filosofica sia possibile recuperare quella capacità prospettica, quella capacità di fare proposte e di guardare lontano che oggi, a partire dall’ambito politico, sembra essere smarrita.
Il modo di procedere proprio di questa disciplina deve abituare a soppesare e a sostenere con argomentazioni coerenti e logicamente fondate le proprie posizioni e, conseguentemente, le proprie scelte e il proprio operato. Da questo esercizio di onestà intellettuale deve discendere la presa di coscienza dinanzi al fatto di appartenere al mondo e la scelta di “parteciparvi” apportando il proprio contributo, attraverso una assunzione di responsabilità nei confronti di quello che si eredita dal passato, nei confronti di ciò che deve essere gestito nel presente e nei confronti degli impegni che devono essere assunti verso le generazioni future.
Occorre quindi imparare o re-imparare a pensare a quello che si fa, tenendo presente quella che Ricoeur definisce unità di ritmo tra lavoro e parola e che ribadisce in un testo del 1955, Storia e verità, quando afferma di “credere nell’efficacia della riflessione, perché la grandezza dell’uomo sta nella dialettica del lavoro e della parola; il dire e il fare, il significare e l’agire sono troppo mescolati perché una opposizione profonda e durevole possa essere istituita tra «teoria» e «praxis»”[43]. Afferma inoltre di non riuscire “a concepire il filosofo come un pensatore solitario. È anche un uomo che vuole pensare il proprio tempo e aiutare gli altri uomini a mutare la loro condizione comprendendola”[44].
Il suo interesse per l’agire umano, la sua attenzione verso il campo dell’azione e verso l’intreccio di morale e politica è una diretta conseguenza della sua partecipazione al movimento Esprit e della scelta di porre al centro della speculazione la persona e lo spazio della sua esistenza, anziché le astrazioni dei filosofi di mestiere. Se l’ispirazione di fondo che sottende le sue indagini è l’attenzione nei confronti della condizione umana e se tutta la sua opera si è configurata come un’antropologia filosofica, allora possiamo essere d’accordo con Jervolino nell’affermare che Ricoeur “è restato fedele in tutta la sua vita all’idea di una filosofia che non si chiude in se stessa ma che diventa un’attività per pensare e promuovere nelle sue molteplici forme l’umanità dell’uomo”[45].
Il valore della sua riflessione mi sembra dunque risiedere nell’elaborazione di un pensiero concreto che procede dall’uomo e ad esso ritorna: non una speculazione fine a sé stessa ma uno studio proteso a interpretare e pensare la prassi, compromesso con le contraddizioni del proprio tempo e chiamato a operare delle mediazioni tra i molteplici richiami del reale. È dunque forte l’invito rivolto agli intellettuali affinché la loro sia una riflessione responsabile, capace di “pensare” vie nuove, di immaginare un altro mondo possibile e di progettare un futuro più umano.
[1]P. Ricoeur, La critica e la convinzione, trad. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1997, pp. 23-24.
[2] P. Ricoeur, Riflession fatta: autobiografia intellettuale, trad. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1998, p. 22.
[3] Ib., p. 26.
[4] Ib., p. 29.
[5] P. Ricoeur, La critica e la convinzione, cit., p.44.
[6] P. Ricoeur, La persona, trad. it. di I. Bertoletti, a cura di P. De Benedetti, Morcelliana, Brescia 1997, p. 21.
[7] Ib., p. 22.
[11] P. Ricoeur, Finitudine e colpa,trad. it. di M. Girardet, a cura di V. Melchiorre, Il Mulino, Bologna 1970, p. 153.
[12] Cfr. O. Rossi, Tra sfida etica ed impegno filosofico, in A. Danese (a cura di), L’io dell’altro. Confronto con Paul Ricoeur, Marietti, Genova 1993, p. 272.
[13] P. Ricoeur, Sé come un altro, trad. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993, p. 448.
[14] Ib., p. 94.
[15] Ib., p. 129.
[16] D. Jervolino, Ricoeur: L’amore difficile, Edizioni Studium, Roma 1995, p. 27.
[17] P. Ricoeur, Il socio e il prossimo in P. Ricoeur, Storia e verità, cit., p. 105.
[18] Ib., pp. 105 – 106.
[19] Ib., p. 106.
[20] G. Campanini, Dall’estraneità alla prossimità, in A. Danese (a cura di), L’io dell’altro. Confronto con Paul Ricoeur, cit., p. 102.
[21] P. Ricoeur, Il giusto, vol. I, trad. it. di D. Iannotta, Effatà Editrice, Cantalupa (Torino) 2005, p. 192.
[22] P. Ricoeur, Giustizia, amore e responsabilità. Un dialogo tra Emmanuel Levinas e Paul Ricoeur, in Il pensiero dell’altro, trad. it. di M. Pastrello, a cura di F. Riva, Edizioni Lavoro, Roma 1999, p. 79.
[23] P. Ricoeur, Sé come un altro, p. 298.
[24] Ibidem.
[25] S. Ricotta, Giustizia, intersoggettività, istituzioni. Ricoeur tra Mounier e Levinas, in AA. VV., Forme della reciprocità. Comunità, istituzioni, ethos, Il Mulino, Bologna 2004cit., p. 231.
[26] Ib., p. 242.
[27]P. Ricoeur, Il socio e il prossimo, cit., p. 115.
[28] P. Ricoeur, Riflession fatta: autobiografia intellettuale, cit., pp. 24-25.
[29] P. Ricoeur, La critica e la convinzione, cit., p. 204.
[30] Ib., p. 211.
[31] Ib. p. 206.
[32] P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 75.
[33] Ib., p. 76.
[34] Ib., p. 78.
[35] Ibidem.
[36] Ibidem.
[37] Ib., p. 92.
[38] Ib., p. 451.
[39] Ib., p. 203.
[40] Ib., p. 201
[41] Ibidem.
[42] P. Ricoeur, Riflession fatta: Autobiografia intellettuale, p. 91.
[43] P. Ricoeur, Storia e verità, p. IX.
[44] P. Ricoeur, La questione del potere. L’uomo non violento e la sua presenza nella storia, trad. it. di A. Rosselli, Marco, Lungro di Cosenza, 1991, p. 135.
[45] D. Jervolino, Introduzione a Ricoeur, Morcelliana, Brescia 2003, p. 76.

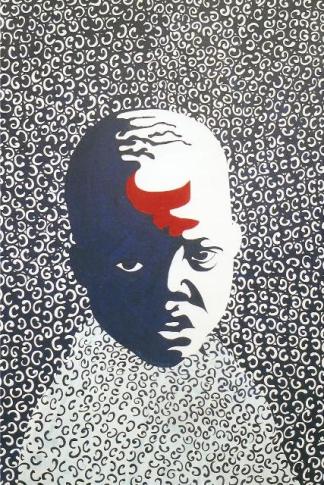

Scrutando il fondale della Vasca dei pesci rossi, viene voglia di fare un tuffo per andare a prendere la perla che Anna Maria sistema di volta in volta dentro una conchiglia con la cura estetica di chi sa scegliere le più belle. Che splendore di energia questo filosofo francese! Ricoeur si occupa di tutto quanto dovrebbe veramente interessare un essere umano, e ne parla con coraggio, vigore, ricchezza e potenza. La filosofia è una garanzia dell’intelligenza, la garanzia che dietro le cose che diciamo c’è un pensiero. Alessandra, nell’ultima puntuale domanda di Anna Maria, relativa alla necessità della filosofia oggi, parla di abitudini a pensare, così dimenticata e persa in questo nostro mondo un po’ sbandato, per non dire infelice, dove le coscienze sono offuscate, imprigionate. Il pensiero, risorsa mirabile dell’uomo, altro non è che la vita della coscienza, è possibilità, potere, liberazione; di queste potenzialità sappiamo farne uso, sappiamo goderne? Saper stare nel proprio spazio di esistenza, saper dare un senso al nostro agire, saper essere felice, dipende molto spesso dall’attenzione concessa alle risorse della coscienza. “Noi lavoriamo solo a riempire la memoria e lasciamo vuoti l’intelletto e la coscienza. Piuttosto la testa ben fatta che piena!” diceva Montaigne. Occorre imparare e reimparare a pensare a quello che si fa, dice ancora Alessandra…, merce rara gli uomini che pensano quello che fanno e fanno quello che pensano! E sempre acutamente sottolinea l’importanza della filosofia come metodo, come modalità di riflessione, di comunicazione e relazione, tanto più necessaria in un mondo così rapido e distratto dove spesso ci si parla per presentare e giustificare se stessi, piuttosto che per ascoltare e riconoscere veramente l’altro. Esistenze un po’ egocentriche e superflue con il sottile piacere o la sottile gioia della prevaricazione. Gioia semplice e forte è invece coltivare il desiderio si capire, afferrare il significato dell’esistenza, “conversare”, nel senso di volgersi verso , trattenersi con se stessi e con gli altri.
Ricoeur è un filosofo “nella vita”, che si rivolge alla vita e agli uomini. La filosofia è un atto di esistenza che aiuta a generare verità. Remo Bodei, in una delle sue ultime ricerche, dice che essa non è simile alla maieutica, ma è essa stessa maieutica, nel significato tecnico di un’arte che presiede la generazione di qualcosa di nuovo. Ci ricorda che in uno dei dialoghi di Platone, il Teeteto, si trova la prima definizione tecnica di filosofia: “Tu soffri le doglie del parto perché sei gravido” dice Socrate, che dichiara di possedere la stessa arte che sua madre usava per far partorire le giovani donne. E come le donne partorienti, anche coloro a cui Socrate applica la sua arte, patiscono le stesse pene, le stesse difficoltà. Chi procrea nel corpo e nell’anima patisce e sopporta il dolore. La generazione del nuovo presuppone la sofferenza. Niente può venire alla luce senza sforzo, o sacrificio; il potere della mia arte, dice Socrate, consiste proprio nel suscitare e nel far cessare questo travaglio. Ciò che più di ogni altra cosa si addice al filosofo che lo rende riconoscibile rispetto agli altri dice Bodei, è un phatos.” Si esce così dall’idea del filosofo solitario, freddo di ragione, preso dal gioco di catturare e analizzare la vita con la mente, immune da ogni passione. “La passione è appropriata per il filosofo, non c’è altro principio del filosofare se non questo. La passione da inizio alla filosofia e la governa” . Mi piace l’idea del filosofo che nel suo compito di ricerca della verità ,” non cancelli la sfera dell’emotività umana giudicata irrazionale o extrarazionale, di una filosofia che non sia lontana dall’ambito degli affetti e delle passioni, che nel suo statuto originario non si costituisce affatto come esercizio puramente razionale, scevro da ogni componente emotiva, poiché essa al contrario è connessa inscindibilmente alla ampia gamma di significati riconducibili alla sfera del pathos.” Suggestiva la simmetria tra un parto corporeo e parto dell’anima, una bella lezione esistenziale l’ammonimento che nessuna generazione del nuovo possa avvenire senza sforzo. Mi piace l’idea del filosofo “ostetrico dell’anima che sia in grado di far partorire coloro che siano alla ricerca della verità.”
La filosofia porta ad esercitare il pensiero, allena a pensare alla vita, aiuta a trasformare il mondo. Il suo spazio è ancora vitale e insostituibile nella democrazia culturale del pianeta.
Grazie ad Anna Maria, grazie ad Alessandra , grazie a Paul Ricoeur, che parlano di filosofia, che inducono a pensare, a ricercare la verità.
Elvira Aglini